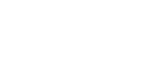Le mezze stagioni sono morte da un pezzo, così come forse le mezze misure. Il buon senso si scontra quotidianamente con la libertà, in un dibattito costante che dovrebbe attraversare altri piani sociali. E i brand non sanno più se misurare le performance, interiorizzare le competenze o lanciarsi nello spregiudicato mondo delle responsabilità.
Benvenutə nella nuova era, segnata da ottimismo e disorientamento. Secondo un sondaggio pubblicato dal World Economic Forum 9 cittadinə su 10, a livello globale, auspicano di vivere in un mondo più sostenibile ed equo nel post-Covid 19.
Non è più possibile far finta di niente, soprattutto perché qualsiasi manager oppure operatore/operatrice della comunicazione sa che l’era del racconto è finita da un bel pezzo. Ora non si tratta più di fare storytelling, ma bisogna concretizzare il pensiero aziendale in uno storydoing fattivo ed efficace, che sappia affrontare la quotidianità e preferibilmente consegnare un mondo migliore.
Ho voluto approfondire queste tematiche con uno dei migliori creativi italiani di sempre, Paolo Iabichino. Scrittore, fondatore dell’Osservatorio Civic Brands con Ipsos Italia, Maestro della Scuola Holden, Paolo è un talento che ci ha visto lungo: con il libro Invertising nel 2009 ha realizzato un vero e proprio “manifesto per un messaggio pubblicitario rinnovato e consapevole”. Ringrazio la sua collaborazione e parto proprio da qui…
Oggi sei “al servizio di realtà che sentono la necessità di voltare pagina”. Quando hai sentito il bisogno di “cambiare”?
A essere sincero, è arrivato nel momento apicale del mio percorso. Dopo 18 anni di Ogilvy ero diventato il Direttore Creativo del gruppo WPP a livello europeo sull’incarico FCA Digital che coinvolgeva tutti i brand del gruppo FCA (su 27 Paesi) per tutti gli asset digitali. Era una gara che avevo seguito direttamente con le eccellenze e i talenti di tutte le agenzie digital del gruppo. Da un certo punto di vista avevo raggiunto il momento più alto della mia carriera, non esattamente il momento migliore per lasciare, ma ho fatto come Mourinho dopo il triplete con l’Inter e senza avere un piano B.
Questo è accaduto perché dopo un anno di quell’esperienza avevo toccato con mano la tossicità del dialogo tra creatività e finanza. Per far tornare i conti spesso si rinuncia a servire i clienti in accordo con la dignità del lavoro e delle persone. Questo è diventato un fatto insopportabile. Nel contempo il CEO di Ogilvy veniva estromesso senza che ci fosse una reale motivazione e ciò aggiungeva un carico di sofferenza a una situazione che già mi procurava del disagio.
A quel punto il mio racconto non risuonava più con il racconto delle organizzazioni a cui prestavo il mio scrivere. Ho lasciato tutto senza avere una exit strategy o un piano B, con il rischio di fare un torto a tutte le persone che circondavano la mia vita. Mi sono però trovato naturalmente posizionato nel mercato grazie a tutto quello che negli anni avevo scritto, detto, insegnato: ero nel territorio del cambiamento. Esaurite le formalità dei colloqui con le altre agenzie che cercavano di capire se avevo voglia di rientrare nei ranghi delle direzioni creative esecutive, ho provato a dare ascolto alle aziende e ai clienti che mi cercavano. Così ho dato voce a quello Iabicus che da anni stava in rete e ho cominciato a scrivere per clienti che in quel momento avevano bisogno di un advisoring di livello sui temi dell’impatto, del purpose design e del cambiamento.
Ho incontrato quello che stavo cercando. Da tre anni mi muovo come Iabicus, rinunciando alle logiche un po’ claustrofobiche e intossicanti del rapporto agenzia/cliente e muovendomi tra gentlemen agreement e chemistry meeting, rifiutando qualsiasi gara (e penso che tutti dovremmo abbandonare questo vizio).

Se dovessi definire ogni decade della comunicazione e del marketing, dagli anni ’80 a oggi, quali parole useresti?
Fatta salva l’esperienza del Carosello la nostra pubblicità non ha avuto un carattere identitario. Abbiamo obbedito di fatto agli influssi d’oltreoceano che su questa disciplina hanno cominciato a costruire molto prima di noi. Se dovessi chiuderla per decadi…
- Gli anni ‘80 sono quelli rutilanti, sono quelli fortunati o quelli meravigliosi che non abbiamo fatto in tempo a vedere, in cui le organizzazioni avevano il nome del fondatore sull’insegna. Entravi in un’agenzia e sapevi esattamente cosa compravi. È stata forse la decade più fortunata per questo mestiere, nel bene e nel male. Perché ha anche creato questo universo glamour di paillettes e lustrini, e che ha purtroppo condizionato l’immaginario con l’introduzione degli stereotipi. Era il frutto inevitabile della commercializzazione della televisione, che snaturava l’approccio pedagogico/culturale della comunicazione.
- In realtà gli anni Ottanta, arrivano allegramente anche negli anni 90, fino alle soglie del 2000. Il vero cambio di passo si ha con il Millennium Bug: con l’arrivo di Internet che impone alla disciplina della comunicazione del marketing uno sguardo diverso. O almeno è quello che abbiamo pensato in molti, che Internet ci potesse riscattare, impiegandoci in una comunicazione più autentica, diretta e immediata. In realtà la storia ci ha dato grandemente torto e te lo dice uno che ha candidato Internet al Nobel per la pace, quindi mi assumo tutte le responsabilità. [Ride]
- La decade del 2010 è segnata in maniera gigantesca dalle crisi, da quella del subprime a quella dell’11 settembre, fino all’ultima dettata dalla pandemia in corso. È una decade fortemente turbolenta e quella che di fatto, secondo me, quella più decisiva negli inevitabili cambi di rotta che qualcuno aveva già cominciato a intravedere nel 2010…
- … e che nel 2020 diventano l’unica e forse l’ultima possibilità che abbiamo per riempire di senso questo mestiere. Se addirittura il papà del marketing Kotler si cimenta con i temi dell’attivismo nel suo ultimo lavoro, significa che indietro non si può tornare. La pandemia lo ha reso straordinariamente evidente e quindi credo che chiunque si occupi di marketing e comunicazione deve mettere in agenda una serie di tematiche che nelle decadi precedenti non erano minimamente nel nostro palinsesto mentale.
Nel tuo ultimo libro, Ibridocene, parli della nostra “età di mezzo”: cos’è cambiato e cosa sta cambiando nella società?
In realtà siamo dentro una trasformazione che dura da talmente a lungo che non possiamo più parlare di cambiamento. Dobbiamo rassegnarci a vivere in un mondo mutevole e cangiante, costretto a rinunciare alle forti polarizzazioni. Non è più un tema per cui valgono ancora il bianco e il nero, perché negli ultimi vent’anni abbiamo scoperto le infinite possibilità di grigio. Ed è qui che viviamo, è un cambiamento destinato a rimanere. A me piaceva molto l’approccio di Bauman quando parlava di modernità liquida perché ci faceva sentire continuamente in movimento, non in cambiamento. E il movimento peraltro non è necessariamente evolutivo. Siamo dentro un’età che ora ci può far fare un passo avanti e due indietro.
Non sappiamo esattamente dove dobbiamo tendere, ma abbiamo tutti abbastanza contezza che ciò che c’era prima non può andare più bene. A me fanno molto arrabbiare quelli che parlano di nuova normalità. Al massimo possiamo parlare di nuova anormalità.
Cosa intendi per “nuova anormalità”?
Stiamo vivendo una trasformazione permanente, non possiamo neanche più parlare di cambiamento, ma di continuo apprendimento. E la cosa veramente epocale (da cui ibridocene) è che per la prima volta nella storia dell’umanità non siamo più costretti a voltarci indietro per leggere la storia perché quello che sta accadendo lo stiamo scrivendo noi.
Noi abbiamo in questo momento la responsabilità di decidere le sorti e il destino dell’umanità dei prossimi 10, 20, 30, 40, 50 anni, pensando alle generazioni in base a come facciamo mercato oggi. Noi possiamo decidere se questo è un se la Terra ha ancora qualche opportunità oppure se questo è un pianeta destinato all’estinzione. Tutto In base alle scelte che facciamo oggi.
Quindi anche il mercato e le scelte di consumo hanno un peso?
Le scelte di consumo stanno diventando scelte politiche e qui si genera l’equivoco: nel momento in cui le scelte di consumo diventano scelte politiche i brand pensano di fare ideologia, di fare politica. Non mi serve questo, non mi serve che tu prenda posizione se ciò significa snaturare la tua ragione d’essere. Ma basta che ti comporti civilmente sul mercato. Mi basta che rispetti le persone che lavorano con te. Che rispetti il consumatore e lo tratti da interlocutore, entri nella dialettica di scambio e non lo consideri un cretino. Mi basta che non sia la crescita l’unico obiettivo che ti poni come impresa.
Chi può prenda posizione, ma lo faccia davvero. Che faccia politica schierandosi. Abbiamo scoperto il valore enorme delle community e abbiamo scoperto il valore tribale dell’aggregazione intorno alle ideologie. Quando scrivevo 15 anni fa che i brand possono diventare come delle religioni perché creano adesioni, ideali e ideologiche, venivo un po’ visto come una specie di esaltato che voleva fare di Invertising una specie di chiesa. Ma oggi è proprio così. Oggi ciò che chiamo Olympic brand (quelli più bravi, più capaci, più ispirati) catalizzano energie importanti per generare impatto e cambiamento nella società civile. L’obiezione può essere “Sì, ma vogliono vendere”. Eh, quindi? Non si può fare profitto in maniera sana? Il capitalismo ha esaurito tutto quello che aveva da dire fino a qui e deve essere ripensato e ridisegnato.
È come se noi ci trovassimo in questo momento a rimappare le principali categorie del nostro vivere. Il fare mercato, il fare scuola, il fare politica, il fare impresa… dobbiamo rimappare tutto se vogliamo davvero accogliere questa età ibrida che continua a tenerci in sospensione su un filo. Siamo come dei funamboli che devono cercare di stare in perfetto equilibrio in un mondo assolutamente mutevole dove anche l’idea stessa di verità è venuta meno.

Come si innesta dunque la Corporate Social Responsibility nella “nuova era ibrida”?
Diciamo che è la nuova linfa. La cosa bella della CSR nel nuovo mondo è che la CSR muore, perché viene meno nella misura in cui è tutto Corporate Social Responsability. È in magazzino perché hai deciso di comprare i pallet etici, anziché prenderli economici nel mercato nero che produce uno scempio, non solo in termini ecologici e ambientali.
Noi dobbiamo capire che la CSR di cui parliamo da qui in avanti è una CSR che innerva tutte le funzioni dell’azienda.
I progetti più felici che ho firmato negli ultimi anni hanno visto la CSR al tavolo con il marketing, con le hr in una logica di change management o addirittura allo stesso tavolo della pubblicità, proprio perché marketing e comunicazione non possono più fare a meno di questa funzione.
Sono diverse le aziende bravissime a proporsi come etiche sul mercato, ma al loro interno non rispettano tali valori. Quale sarà il loro futuro?
Quelle aziende che realmente non risulteranno sinceramente impegnate nel definire nuovi patti con i consumatori, perderanno credibilità nella matrice narrativa valoriale (l’etica, la sostenibilità, l’impegno, l’attenzione, ecc).
Oggi o cambi veramente il tuo impatto sul mercato oppure devi giocare un altro campionato, dove la tua vetrina finisce per battagliare con quella di Amazon, con un’assenza totale di valori. In questo caso la battaglia diventa costare di meno, marginare di più, abbassare inevitabilmente la qualità dei prodotti. Il loro futuro dunque è quello di estinguersi o di cambiare profondamente.
Il caso di Philip Morris è evidente: faceva sigarette, farà qualcosa d’altro. Oppure diventi commodity, nessuna affezione, diventi come un tovagliolo di carta, perdi completamente tutto il carisma e l’ascendente che invece i grandi e alcuni piccoli brand stanno recuperando in maniera importante presso i consumatori.
I “nuovi” consumatori stanno arrivando. Quelli che domani avranno un potere d’acquisto maggiore difficilmente compreranno brand che non saranno cambiati. Sarà molto più probabile che scelgano le marche da portare nelle proprie vite. C’è una grande differenza tra scegliere e comprare. C’è una grande differenza tra la fidelizzazione e la fiducia. Le marche che resteranno sono quelle che capiscono e abbracciano questo panorama.
Puoi darmi esempio che hai particolarmente apprezzato? E perché?
Sono abituato a lavorare per gente che ha voglia di lasciare un’impronta. Recentemente sono stato su un set fotografico di un’azienda che produce pet food e si impegna in una campagna che non vende nulla, se non segnalare al suo pubblico l’emergenza incendi di quest’estate, collegare le emergenze incendi all’emergenza ambientale e dire “riportiamo la natura nel pianeta“.
Capisci che se uno che vende cibo per cani e gatti impegna i propri soldi per lanciare messaggi di questo tipo, significa che questo nostro lavoro sta acquisendo una dignità nuova. La nostra responsabilità è quella di capire “chi lo fa” o “chi ci è”. La nostra responsabilità è quella di prestare il nostro scrivere solo e soltanto a quelle imprese che hanno voglia non solo di fare la réclame sostenibile, ma anche di lasciare un’impronta significativa.
Non è solamente lo scatto fotografico, la pagina, l’affissione, l’investimento media. È anche mettere imprenditori e imprenditrici a contatto con le realtà del territorio e con le comunità in una logica di partnership trasformativa che permetta loro effettivamente di impattare sulle comunità, sul territorio, sulle società e non solamente di impattare sui comunicati stampa.
Possiamo definirlo come un esempio di Corporate Social Responsibility?
Questo non lo considero un vero e proprio caso di CSR. A me piacerebbe che noi provassimo a fare un esercizio, ossia sostituire la C di Corporate Social Responsibility con una qualsiasi altra parola che ci possa aiutare a decodificare meglio il tempo che sta arrivando.
Cosa intendi?
Pensa a mettere CSR e dire Communication Social Responsibility. Oppure Cultural Social Responsability. Vedi come cambia completamente la prospettiva? Community Social Responsibility. No? Consumer Social Responsibility. Quanto è importante la responsabilità? Cosa stiamo facendo noi per attrezzare il consumatore a delle scelte consapevoli? Oltre a risarcire, oltre a rivedere le nostre filiere, stiamo facendo un’educazione al consumo?
Creare palestre di consumo responsabile, come fa Altromercato per esempio, per citare una campagna abbastanza importante sulla quale mi sono cimentato. Altromercato è una realtà che ha deciso di riposizionare completamente il racconto della sostenibilità, dell’etica e del rispetto delle uguaglianze. Ed è diventato un brand che è impegnato non tanto nel dire “quanto è bravo a fare quello che fa” (perché lo fa da trent’anni), quanto nell’educazione civica di un consumo responsabile. Quasi fosse un’associazione di consumatori.
È questa la partita da giocare. Oggi per esempio un ragazzo di 19 anni pretende un packaging di carta; se non è di carta, lui non compra. Se tu “fai il bullo” con il packaging di carta a quattro colori sulle pagine dei quotidiani, sei un boomer. Questo tipo di riprogettazione oggi è, come dire, un prerequisito per stare sul mercato. Quindi quando non avrai più cartucce da sparare nel territorio del makeup narrativo votato alla sostenibilità che passa dal packaging, dalle rinnovabili, dall’inclusione, dal gender gap, cose che gli z danno per obbligatorie per guardare dentro il tuo sito, quando non avrai più queste vanterie, dove ti affacci?
La grande responsabilità che dobbiamo assumerci oggi è proprio forse la Consumer Social Responsibility, cioè allenare i consumatori e non ammiccare agli z e fare i giovani. È attrezzare le responsabili (e i responsabili) d’acquisto, le famiglie… ed è da loro che deve partire un nuovo modo di consumare, di guidare, di viaggiare, di vestire, di mangiare, se vogliamo realmente costruire un futuro più sostenibile. Altrimenti è solo storytelling.

Come ha influito la pandemia (e il lockdown) nella società e nel modo di comunicare dei brand?
Quello che stiamo attraversando di fatto ha accelerato in maniera definitiva una serie di tematiche che avevamo in qualche modo intravisto qualche anno fa e che oggi abbiamo scoperto essere assolutamente necessarie.
Ciò che mi è piaciuto vedere durante il lockdown è il grande potere carismatico che ancora hanno quei brand che sono riusciti ad assicurare le merci nei supermercati e nei negozi. Penso a un bambino di 6 anni, spaventato da quello che sta succedendo, chiuso in casa da giorni, che trova la sua colazione. Nel dissesto totale trova il suo barattolo di biscotti, la sua marmellata, la sua fetta biscottata, quei beni che escono dal loop dell’essenzialità e tirano fuori la rilevanza della relazione tra consumatore e brand.
Ancora adesso il Parmigiano Reggiano è tra i miei clienti. Ricordo uno spot che abbiamo confezionato in 48 ore con il messaggio del Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, che diceva “Non andate a saccheggiare i supermercati, perché ogni giorno arriverà nelle vostre case. Continuiamo a lavorare in sicurezza“. Quando un brand si innesta su questo tipo di semantica diventa inattaccabile. Non devi più puntare sul riacquisto fidelizzante, perché hai creato quel legame di fiducia che ti permette di essere presente nella vita delle persone. E quindi c’è un’adesione totale, valoriale, io ti compro, ti scelgo, perché mi rappresenti in qualche modo, perché il nostro legame è significativo.
E qui non c’è TikTok. Qui c’è tutto quello che il brand è stato capace di fortificare nel corso delle settimane, dei mesi e degli anni e che la pandemia ha reso più o meno evidente. Da una parte gli eccessi di retorica un po’ pasticciata, dall’altra invece la verità di chi dice “Oh non andare a creare assembramenti per portare a casa un prodotto che ami perché tanto noi ci siamo domani, ci siamo dopodomani, la pandemia non ferma il lavoro dei casari”.
Abbiamo tutti un’opportunità per migliorarci?
Tutti, nessuno escluso, abbiamo una importante opportunità di miglioramento. E io vorrei che tutti imparassimo a rinunciare alla dichiarazione di miglioramento e ad agire con azioni concrete. È questa la grande discriminante del futuro. Cercare di capire se questo percorso di evoluzione, di questo mestiere e del nostro modo di stare nel mondo, può rinunciare alle vetrinizzazioni a cui siamo abituati.
Pensa a Fedez che va in giro in Lamborghini a distribuire migliaia di euro fuori dal finestrino per poi fare una storia di Instagram. E pensa invece al grande lavoro dell’elemosiniere del Papa che ogni notte se ne va a spasso per Roma e fa la stessa cosa, probabilmente con una macchina anche più potente, ma senza fare storie su Instagram. Be’, senza nulla togliere alla bontà del lavoro che stanno facendo i Ferragnez su questi temi, mi viene un po’ da storcere il naso quando vedo l’iper narrazione, quasi dovessi convincere di quanto bravo sei, quando invece le persone in questo momento sanno riconoscere in autonomia dove sta la sincerità di un’azione solidale e dove c’è invece una costruzione narrativa.